Nel cuore del parco del Marguareis, fra tracce umane, pascoli e montagne vive
Ci sono luoghi che, per farsi conoscere davvero, chiedono silenzio e attenzione. Così è stato per Carnino, piccolo villaggio tra le rocce e i pascoli dell’alta val Tanaro, dove abbiamo conosciuto il cuore pulsante del parco del Marguareis.

In breve
I guardiaparco del Parco del Marguareis ci hanno spiegato come dove la protezione dell’ambiente si intreccia con la presenza e il lavoro delle persone:
- La biodiversità si difende anche con scelte apparentemente controintuitive, come il pascolo turnato o il recupero di prati.
- L’associazione fondiaria Carnino è un esempio concreto di gestione collettiva e sostenibile, capace di rivitalizzare l’economia locale tutelando allo stesso tempo il paesaggio.
- I parchi oggi svolgono anche un ruolo sociale ed educativo, favorendo pratiche agricole responsabili, prevenzione del dissesto idrogeologico e intrecciando legami tra comunità e territorio.
Non è stato il sole di luglio ad accoglierci al rifugio di Carnino, nel parco naturale del Marguareis, ma un temporale estivo che ci ha accompagnati dall’inizio della nostra visita insieme al gruppo dell’academy di giornalismo costruttivo ed ecologico di Italia Che Cambia. Eppure, tra nuvole basse e sentieri bagnati, abbiamo scoperto un mondo vivo, complesso e sorprendente.
A farci da guida Massimo Sciandra, il guardiaparco referente dell’area dell’alta valle Pesio e Tanaro – una figura a metà tra custode e narratore – che ci ha offerto uno spaccato reale di cosa significhi concretamente gestire una zona protetta come questa. Non si tratta solo di preservare paesaggi o specie rare: dietro c’è un lavoro quotidiano fatto di monitoraggi, manutenzioni, continui confronti con allevatori e residenti, compromessi a volte difficili e scelte lungimiranti.

Seduti intorno al lungo tavolo del bar della foresteria – luogo che si presta a una pausa lungo il sentiero che unisce il rifugio Mongioie al Don Barbera – con il profumo di caffè e di crostata che si mescolavano all’aria di montagna, abbiamo ascoltato le voci appassionate di Sciandra e di Annalisa Franco, anche lei guardiaparco alle Aree protette delle Alpi Marittime e tecnico faunistico.
Quando lo sguardo si distraeva qualche secondo e finiva col soffermarsi a osservare l’incanto della pioggia battente sul vetro, la selvaticità del vallone sembrava così palese da apparire quasi rimasta intatta nel tempo. Eppure porta i segni profondi della pastorizia, dell’emigrazione, delle guerre e dell’abbandono. I pascoli abbandonati, i casolari in pietra, le mulattiere e perfino i resti delle fortificazioni militari raccontano una storia di presenza umana intensa, in contrasto con l’apparente isolamento attuale.
Ecco che l’impegno di un parco oggi non si limita alla conservazione della biodiversità e alla salvaguardia della flora e della fauna – che in quest’area sono eccezionalmente ricche, come ci ha spiegato Annalisa Franco – ma si estende anche alla cura del territorio, alla manutenzione della rete sentieristica e al sostegno delle comunità locali e alla promozione della cultura. Sciandra partecipa in prima persona a interventi concreti come la manutenzione dei sentieri e il recupero di pascoli antichi, intervenendo persino per contrastare l’avanzata della vegetazione nei terrazzamenti abbandonati, come quelli proprio sopra a Carnino.
I due guardiaparco ci hanno spiegato che in alcuni casi creare radure all’interno dei boschi – ossia tagliare selettivamente alberi in punti strategici – genera benefici significativi per la biodiversità. Una diversità nella struttura del bosco infatti, con alberi di diverse altezze, zone dense e radure, crea microclimi e nicchie ecologiche. Questo favorisce una gamma più ampia di specie: piante erbacee, orchidee, insetti (come farfalle, api), volatili, pipistrelli e piccoli mammiferi amano queste zone soleggiate e meno ombrose.
La funzione dei parchi, dunque, non è quindi solo conservativa, ma anche sociale ed economica, in linea con il principio che lo sviluppo delle comunità è parte integrante della missione di un’area protetta. Uno dei temi che ci ha colpiti è stata la gestione dei pascoli. Il parco, pur nella sua vocazione naturale, deve infatti convivere con le attività economiche tradizionali della zona, come la pastorizia. Trovare un equilibrio tra tutela ambientale e continuità delle pratiche agricole è una delle sfide più critiche. Sciandra ci ha raccontato le loro idee per migliorare la rotazione dei pascoli, prevenire il degrado del suolo e coinvolgere attivamente chi questo territorio lo vive da generazioni.

L’ASSOCIAZIONE FONDIARIA CARNINO
Per prevenire rischi idrogeologici e incendi e allo stesso tempo anche rilanciare le attività agricole e pastorali locali si è pensato di recuperare i cosiddetti terreni “silenti”, quelli cioè con proprietari ignoti o irrintracciabili. Proprio per permettere il pascolo controllato dei terreni, nel 2012 è stata fondata l’associazione fondiaria Carnino, una delle prime in Italia. Grazie all’affitto agli allevatori, i fondi sono stati migliorati con impianti idrici e vasche mobili, fondamentali per praticare un “pascolo turnato” che tutela il suolo e le risorse idriche.
Ma cos’è e come funziona un’associazione fondiaria? Le associazioni fondiarie sono unioni volontarie di proprietari di terreni agricoli e boschivi – spesso frammentati, abbandonati o inutilizzati – che scelgono di gestirli collettivamente per renderli nuovamente produttivi. I proprietari aderiscono, mantenendo però la piena proprietà dei terreni. Nel frattempo l’associazione redige un piano di gestione, affitta i terreni a chi li coltiva o chi li destina al pascolo nel rispetto delle buone pratiche ambientali e cura la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree conferite. Un modello di gestione comunitaria innovativo e praticabile, capace di rivitalizzare l’economia rurale senza ledere il diritto di proprietà.

I PARCHI OGGI: OLTRE L’IDEA DI UNA NATURA INTOCCABILE
Quando pensiamo a un parco naturale, il nostro immaginario ci tratteggia nella mente un luogo intatto, protetto da qualsiasi intervento umano: niente cemento, niente caccia, niente disturbo. Un rifugio per la natura. Ma l’incontro con Sciandra e Franco ci ha portati a rimettere in discussione questo stereotipo. Perché a volte per aumentare la biodiversità, è necessario contrastare l’avanzata del bosco o permettere un pascolo controllato, ad esempio.
Sembra quasi un paradosso: tagliare alberi per aiutare la natura o favorire l’allevamento per proteggere gli ecosistemi. Eppure in un paesaggio profondamente modificato dall’essere umano come quello delle Alpi Liguri, l’assenza totale di intervento non sempre garantisce equilibrio. Ecco perché il ruolo dei parchi oggi è molto più complesso e meno “romantico” di come spesso lo immaginiamo: non si può solamente proteggere ciò che è rimasto, ma bisogna anche accompagnare attivamente i territori verso forme di coesistenza tra natura e presenza umana. Anche le pratiche agricole, se portate avanti con attenzione e visione ecologica, possono diventare strumenti di tutela, anziché minacce.
«Non si può proteggere qualcosa escludendo le persone», ci ha detto Sciandra quel pomeriggio in diverse forme, quasi a voler condensare in poche parole l’anima di questo luogo. Nonostante la pioggia – o forse proprio grazie a lei – il piccolo villaggio di Carnino ci è apparso in tutta la sua autenticità: un luogo dove natura e attività umane si confrontano e dialogano ogni giorno, alla ricerca di una convivenza possibile.









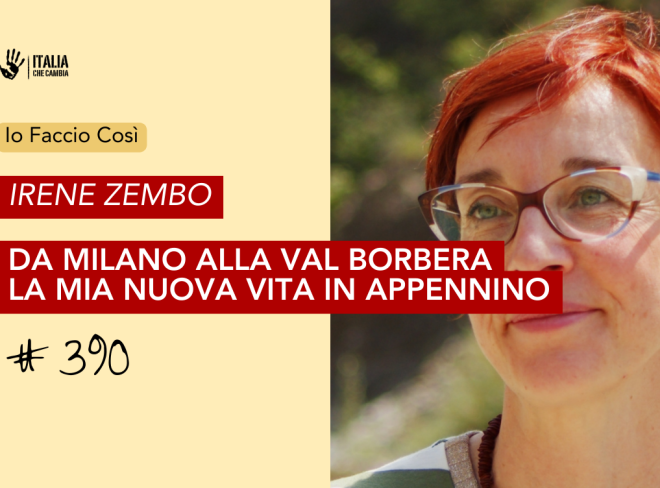




Commenta l'articolo
Per commentare gli articoli registrati a Italia che Cambia oppure accedi
RegistratiSei già registrato?
Accedi