Senza bandi né padroni: il collettivo Giuseppefraugallery e l’arte che prende posizione
Nel Sulcis, tra miniere dismesse e paesaggi marginalizzati, il collettivo Giuseppefraugallery riscrive le regole dell’arte contemporanea con pratiche radicali, relazionali e comunitarie.

In breve
Giuseppefraugallery è un collettivo artistico nato nel Sulcis nel 2009:
- Non si tratta di una galleria d’arte tradizionale, ma di un progetto radicato nella memoria collettiva e nella storia mineraria del territorio
- Dalla lotta operaia alla pedagogia radicale, i progetti del gruppo si fondano su relazioni reali con le comunità locali e rifiutano logiche istituzionali come bandi e finanziamenti pubblici.
- La Scuola Civica d’Arte Contemporanea, da loro avviata nel 2014, è un’opera pubblica vivente: gratuita, inclusiva, aperta a tutte e tutti, pensata per trasformare l’arte in un processo collettivo e accessibile.
- Promuove un’economia etica e di prossimità, che restituisca identità ai territori e alle persone, opponendosi ai modelli predatori e turistici dominanti.
Il collettivo Giuseppefraugallery nasce nel 2009. Attualmente è formato da Eleonora Di Marino, Pino Giampà e Riccardo Oi, ma nonostante il nome non si tratta di una galleria: ogni scelta, a partire dal titolo, si radica in una storia più ampia, collettiva, identitaria. Giuseppe Frau infatti è uno dei tanti nomi di minatori incisi su una parete del Museo Carbone, nella grande miniera di Serbariu, a Carbonia. Gallery invece e un riferimento diretto alle gallerie delle miniere stesse. La loro base operativa è nel villaggio Normann, a Gonnesa, luogo simbolico del Sulcis, terra caratterizzata da una complessa storia mineraria e da contrasti sociali ed economici, spesso affiancata all’etichetta di area tra le più povere dell’isola e del panorama europeo.
Il seme di questo progetto ha radici lontane. I membri, originari del territorio, pur vivendo altrove avevano iniziato già prima del 2009 a organizzare sporadicamente interventi mirati, tesi a ricostruire un background culturale condiviso e a gettare le basi di un linguaggio identitario, solido e radicato. La volontà, fin da subito, era quella di riportare valore all’isola anche attraverso le reti di contatti maturati fuori dalla Sardegna. Così, nella prima residenza artistica ospitata dal collettivo, si sono aperte le porte ad artisti e artiste internazionali, veicolo non solo delle loro esperienze, ma anche di riflessioni sul valore di un territorio come il Sulcis, oltre le etichette.

Trasformare la crisi in relazione
«All’epoca era necessario reagire», raccontano le persone che costituiscono oggi il collettivo. «Portare avanti un discorso culturale era un’urgenza, un modo per rispondere alla condanna implicita che il nostro territorio sembrava subire. Non si trattava solo di cercare nuovi linguaggi, ma di ripensare da zero le forme stesse dell’arte, senza volerci definire artisti in senso stretto». Sin dai primi interventi pubblici, spesso confusi con atti di attivismo ambientale, il collettivo ha scelto di agire in risposta a bisogni concreti.
«Portavamo nuove istanze perché sentivamo il bisogno di dare, attraverso l’arte, un contributo concreto a questioni sociali reali. Uno degli episodi più emblematici fu il coinvolgimento nelle proteste degli operai in lotta. L’attivismo quindi è stato per noi la chiave per entrare in contatto con il territorio, per comprenderne le necessità». Fin dall’inizio il collettivo ha concepito l’arte come mezzo per attivare processi collettivi e relazionali. «Il nostro lavoro ha sempre cercato un contatto diretto con le comunità. Non si trattava di portare una forma d’arte dall’esterno, ma di partire dai bisogni espressi dal basso. Le nostre prime forme di intervento erano profondamente relazionali».
Le esperienze con gli operai portarono alla realizzazione di performance partecipate, strumenti di espressione e organizzazione della protesta, replicate poi anche in altri territori. Nel 2014 il Comune di Iglesias ha affidato ufficialmente al collettivo la realizzazione di un’opera pubblica: così è nata la Scuola Civica d’Arte Contemporanea, progetto permanente pensato per generare relazioni durature con le comunità locali.

Dalla Giuseppefraugallery, la Scuola Civica d’Arte Contemporanea
La Scuola, concepita come un’opera d’arte pubblica, è un progetto di pedagogia radicale; è uno spazio aperto, senza programmi fissi né requisiti formali. Masterclass, residenze e laboratori si susseguono in base ai contesti, affrontando temi che vanno dalla riqualificazione urbana alla cura del paesaggio, fino all’economia di pace. Le opere sono frutto di un processo condiviso: «Nessuno ha l’idea giusta da cui partire. Tutti partecipano, si discute, si scarta, si ricomincia. Finché si perde anche il senso di chi ha avuto l’idea iniziale. Così nasce qualcosa di realmente collettivo».
«Se dovessimo definire la nostra forma di resistenza, diremmo che è stata – ed è tuttora – la capacità di restare. Sarebbe bello se non ci fossero conflitti, se tutto funzionasse, ma non è così. In Sardegna tutto spesso sembra votato a una continua smontatura: fai qualcosa e subito sembra già appartenere al passato. Ma noi ci siamo ancora».
Non vogliamo un’economia predatoria, turistica, di passaggio, ma un’economia etica, capace di dare identità alle comunità
Una scelta del collettivo che ha dato vita alla Scuola è stata anche quella di non voler portare un linguaggio “coloniale” dell’arte contemporanea né imporre un’estetica dall’alto. «Non siamo mai stati legati a un solo progetto, a una singola comunità o a una specifica modalità operativa», raccontano. Ma nonostante le frizioni iniziali con alcune realtà locali, il collettivo è andato avanti e successivamente i contrasti si sono trasformati in collaborazioni. «Alla fine siamo finiti a lavorare insieme. Perché non siamo qui per imporre qualcosa, ma per partecipare».
La Scuola nasce proprio per rendere l’arte accessibile, vicina. «Il linguaggio dell’arte contemporanea è semplice, ma è stato spesso reso complesso da sovrastrutture culturali che lo hanno allontanato dalle persone. Noi cerchiamo di riaprire quel varco». La volontà è quella di rispondere a bisogni reali, migliorare luoghi e relazioni. «Non vogliamo un’economia predatoria, turistica, di passaggio, ma un’economia etica, capace di dare identità alle comunità. E dunque l’arte è utile quando sa rigenerare, prima ancora dei luoghi, le persone».
Fra gli interventi più simbolici ci sono quello al mercato civico di Iglesias, trasformato con la realizzazione del murale d Flavio Favelli, ma anche il recupero della facciata con l’intervento di Stefano Boccalini e la messa in opera del pavimento del collettivo Giuseppefraugallery, in collaborazione con volontari e amministrazione. «Se la scritta “Civico Mercato – Civica Terra” sembra esserci sempre stata, allora è riuscita». Ma una menzione va fatta anche al Belvedere Norman inaugurato nel 2024, nato dalla collaborazione fra l’architetto Francesco Careri e gli abitanti del villaggio stesso.

Liberi dai bandi, libera progettazione
Uno dei principi cardine del collettivo Giuseppefraugallery è il rifiuto dei bandi pubblici. «Tutto quello che abbiamo fatto è stato realizzato senza bandi, senza vincoli esterni. Questo ci ha permesso di essere liberi, di prenderci il tempo necessario. Se un progetto ci richiede anni, va bene così. Non abbiamo fretta: viviamo qui». Anche la Scuola Civica segue questa linea: è gratuita, autofinanziata, sostenuta da crowdfunding e collaborazioni.
«Quando lavoriamo con associazioni che partecipano a bandi accettiamo il partenariato, ma non ci snaturiamo». Oggi la Scuola è riconosciuta dal Ministero della Cultura come Luogo del Contemporaneo, ossia spazio con identità strutturata di luogo dedicato alla promozione, esposizione e valorizzazione dell’arte contemporanea. «Il luogo del contemporaneo è dove siamo noi, dove operiamo. È un concetto vivo».










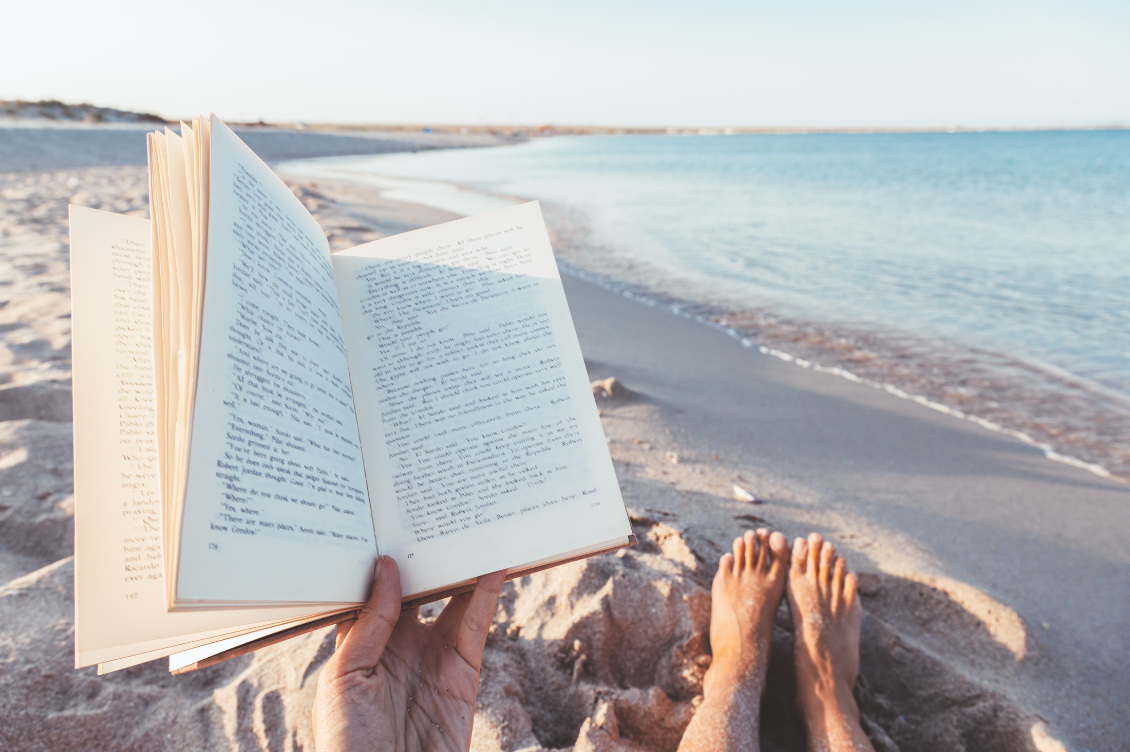





Commenta l'articolo
Per commentare gli articoli registrati a Italia che Cambia oppure accedi
RegistratiSei già registrato?
Accedi