La processionaria è davvero un nemico da combattere?
L’etologa Chiara Grasso sfata alcuni pregiudizi sulla processionaria, la larva della falena a cui vengono comunemente attribuiti comportamenti dannosi per piante e animali. Ma è davvero così?

Quando si parla della processionaria spesso si scatena un senso di allarme: immagini di foreste infestate, pini defogliati e pericoli per cani e bambini. Ma questo timore è giustificato? La processionaria è davvero un insetto da combattere senza pietà oppure ha un ruolo ecologico importante? In questo articolo cercheremo di comprendere meglio chi è, come vive, quali sono i suoi effetti sull’ambiente e come gestire il contatto con questo lepidottero senza inutili allarmismi.
Chi è la processionaria?
La processionaria è il nome comune di alcune specie di lepidotteri appartenenti al genere Thaumetopoea, tra cui la Thaumetopoea pityocampa – processionaria del pino – e la Thaumetopoea processionea – processionaria della quercia. Si tratta delle larve di alcune falene che, appunto nella fase larvale, formano le caratteristiche file ordinate: le “processioni” da cui prendono il nome. Questi insetti si trovano principalmente nelle regioni temperate d’Europa, Nord Africa e Asia Minore, prediligendo alberi come pini, cedri e querce. Le larve nascono a fine estate e costruiscono nidi sericei tra i rami, dove si rifugiano durante l’inverno. Con l’arrivo della primavera, scendono in fila indiana per interrarsi e trasformarsi in crisalidi, per poi emergere come falene nei mesi più caldi.
Il ruolo ecologico
Nonostante la sua cattiva reputazione, la processionaria non è solo un flagello per gli alberi. Come ogni essere vivente, essa ha diverse funzioni all’interno dell’ecosistema. Ecco quali:
- Essere fonte di cibo per altri animali: le larve della processionaria sono una risorsa alimentare per numerosi predatori, tra cui uccelli come la cinciallegra, pipistrelli e insetti parassitoidi, che contribuiscono naturalmente al loro controllo.
- Favorire la biodiversità: la sua presenza stimola la comparsa di altri organismi, come funghi e batteri decompositori, che aiutano a mantenere l’equilibrio naturale.
- Regolare la crescita degli alberi: sebbene possano defogliare un albero, raramente lo uccidono. Anzi, spesso ne stimolano la ricrescita e la resistenza. In un ambiente sano, le piante colpite si riprendono senza difficoltà.

Pericoli per esseri umani e animali
La preoccupazione principale legata riguarda i peli urticanti che le larve sviluppano a partire dal terzo stadio di crescita. Questi peli contengono una tossina, la thaumetopoeina, che può causare reazioni allergiche e irritazioni cutanee o respiratorie. Quando la processionaria si sente minacciata, può rilasciare questi peli nell’aria come strategia difensiva, rendendoli facilmente inalabili e pericolosi per gli esseri umani e gli animali domestici.
Sintomi del contatto con la processionaria
Negli esseri umani la processionaria provoca prurito, arrossamento, dermatiti, problemi respiratori, congiuntiviti se i peli entrano negli occhi. Nei cani invece si verificano salivazione intensa, gonfiore e arrossamento della bocca, difficoltà a deglutire e necrosi della lingua nei casi più gravi. Il periodo di maggiore rischio è tra febbraio e maggio, quando le larve scendono dagli alberi per interrarsi. I boschi di conifere e le foreste di latifoglie del Nord e del Centro Italia sono particolarmente esposti.
Come proteggere umani e animali
- Evitare le zone infestate nei periodi critici: Durante la primavera, prestare attenzione nei boschi di pini e querce, specialmente con bambini e animali.
- Non toccare nidi e larve: i peli urticanti possono volare nell’aria e causare irritazioni anche senza contatto diretto.
- Proteggere i cani: evitare di lasciarli liberi in aree a rischio e, se entrano in contatto con le larve, lavare subito la bocca con acqua tiepida (senza strofinare!).
- Segnalare le infestazioni: in caso di nidi in parchi pubblici o aree urbane, informare le autorità per interventi di controllo ecologico.
La processionaria soffre di una cattiva reputazione dovuta alla scarsa conoscenza del suo ruolo ecologico
Strategie ecologiche per il contenimento
La demonizzazione della processionaria ha spesso portato a interventi drastici e dannosi per l’ambiente, come l’uso indiscriminato di insetticidi. Tuttavia esistono metodi naturali ed efficaci per limitarne la diffusione, senza compromettere l’equilibrio ecologico. Un esempio è l’installazione di casette nido per uccelli insettivori, come cince, codirossi e pigliamosche. Nei Paesi Bassi questo metodo si è dimostrato molto efficace nel controllo biologico della processionaria, riducendo la necessità di pesticidi chimici e favorendo la biodiversità. Anche in Italia, il Comune di Trento ha adottato un’iniziativa simile, installando circa 300 casette per favorire la nidificazione di uccelli predatori di processionarie.
Convivere con la processionaria: un approccio consapevole
La processionaria non è un nemico da sterminare. Come molti altri insetti, soffre di una cattiva reputazione dovuta alla scarsa conoscenza del suo ruolo ecologico. Se è vero che può rappresentare un pericolo in determinati contesti, è altrettanto vero che il panico e l’eliminazione indiscriminata non sono la soluzione migliore. Un ecosistema in equilibrio è in grado di autoregolarsi, tenendo sotto controllo le popolazioni di processionaria senza interventi drastici.
Educare le persone al rispetto della natura, promuovere metodi di gestione sostenibili e sensibilizzare sulla convivenza con la fauna selvatica sono passi fondamentali per affrontare la presenza di questo insetto in modo responsabile. Ogni organismo ha un ruolo nel grande mosaico della biodiversità e la processionaria non fa eccezione: impariamo a gestirla con intelligenza, invece di combatterla con paura.






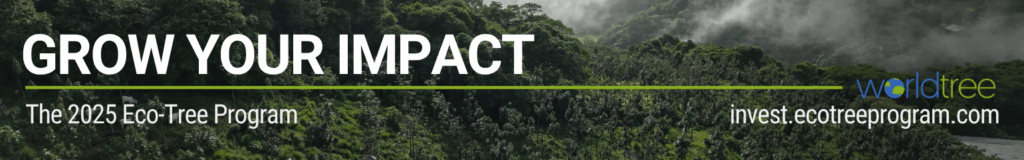







Commenta l'articolo
Per commentare gli articoli registrati a Italia che Cambia oppure accedi
RegistratiSei già registrato?
Accedi